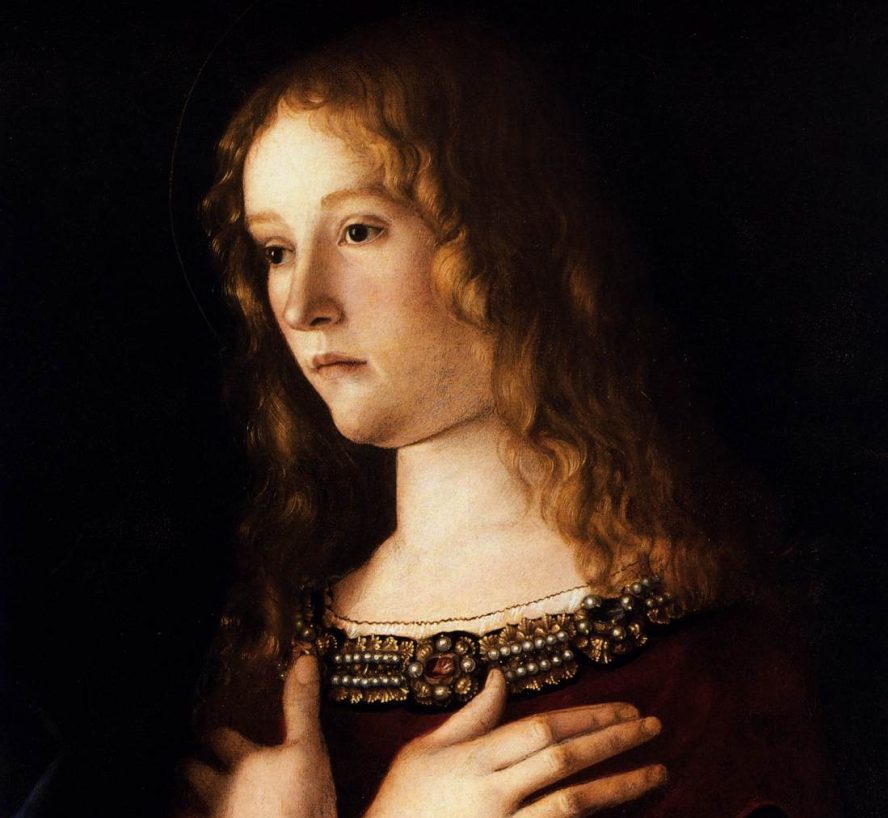
“L’amore può tutto, l’amore osa tutto”. La Maddalena di Rilke e la storia del sermone ritrovato
Cultura generale
Marilena Garis
Charles Baudelaire, il padre del modernismo europeo, diceva di andare in fondo all’ignoto per scoprire il nuovo. Si può dire anche oggi, malgrado tutto, che la realtà sia solo quella che risulta dalla cronaca deprimente, e talvolta agghiacciante di un giornale, si chiedeva Aldo Moro, il cui pensiero mirava a ben altro?
Nella rivista “Studium” del 1945, appena finita la guerra, erano presenti tutte le premesse che avrebbero guidato la sua azione politica, come si evince in queste parole che sono assolutamente nuove per quei tempi: “Lo spirito della pace è spirito di lotta e di conquista. L’annunzio evangelico, teso com’è a rasserenare, equilibrare, pacificare, può essere tuttavia una dichiarazione di guerra per la straordinaria necessità, nella condizione umana, di conquistare il bene nel quale riposare con una fatica senza interruzione. La pace, che è tutt’uno con la verità, verità operosa e creatrice di intese, non è un dato esterno al quale si possa comodamente aderire. Non ci possono essere parassiti della pace, perché questa è un perpetuo ansioso travaglio e si rifiuta a coloro che non hanno l’ardire di guardare in se stessi e negli altri, per trovare in una compiuta presenza nel mondo il senso pacificatore della fedeltà alla vita. Perché questo vuol dire essere in pace: essere fedeli alla vita, costi quel che costi, dire di sì, con serenità cosciente, all’impulso incoercibile, ma equivoco dell’essere. La pace vuol dire rinunzia alla rinunzia, accettazione dello scomodo stato di essere uomini (e non per un minuto, ma per sempre), adempimento dei delicati doveri della vivezza e della intelligenza. Non possiamo parlare di pace, finché gli uomini restano così estranei, così freddi, così diversi l’uno accanto all’altro, mentre la vicinanza è un peso fastidioso dal quale ci si vorrebbe liberare o che si tenta vanamente di dissolvere con la tecnica artificiosa dell’arte dei contatti sociali. Non c’è pace, finché non siano stati riconosciuti i diritti ed i doveri dell’intelligenza e questa, diventata eguale alle sue possibilità, non abbia fatto luce intorno, aprendo coraggiosamente orizzonti a tanta verità, quanta è necessaria per vivere. Non c’è pace infine, dove non c’è l’impegno, la gioia di vivere, dove non ci sollecita la necessità di essere uomini né ci alletta il cammino difficile, per ritorni ed incertezze, di una rinnovata conquista, di una fede consolatrice, di una ineffabile speranza. Per mancanza di intelligenza e di vivacità, malgrado il nostro desiderio, siamo così lontani dalla pace. Ed oggi, come cristiani, corriamo il pericolo di perdere un’ultima occasione, di fare una definitiva rinuncia, se, resi accorti dell’estremo rischio, non facciamo sorgere in noi lo spirito della pace, il quale renda la vita coraggiosa, operosa, affaticata, ma non stanca, per una conquista infinita da compiere”.
Il 20 gennaio 1977, sul quotidiano “Il Giorno”, lo statista scrisse parole salvifiche e premonitrici per una redenzione politica, per uno scatto in avanti simile all’ignoto poetico di Baudelaire. Le frasi sono autentiche, sibilline, ma anche lontane da una percezione comune, politica ed istituzionale, perché Moro è stato e rimane un iniziatore capace di tuffarsi nell’abisso del nuovo senza concedere nulla all’arbitrario e al parziale. Non ci si discosta dalle premesse del 1945, come si può notare. Moro parla in modo assoluto: “Il bene non fa notizia. Quello che è al suo posto, quello che è vero, quello che favorisce l’armonia è molto meno suscettibile di essere notato e rilevato che non siano quei dati, fuori della regola, i quali pongono problemi per l’uomo e per la società. Ma questa ragione, per così dire, tecnica, questo costituire sorpresa, questo eccitare la curiosità non escludono certo che, nella realtà ci sia il bene, il bene più del male, l’armonia più della discordia, la norma più dell’eccezione. Penso all’immensa trama di amore che unisce il mondo, ad esperienze religiose autentiche, a famiglie ordinate, a slanci generosi di giovani, a forme di operosa solidarietà con gli emarginati ed il Terzo Mondo, a comunità sociali, al commovente attaccamento di operai al loro lavoro. Gli esempi si potrebbero moltiplicare. Basta guardare là dove troppo spesso non si guarda e interessarsi di quello che troppo spesso non interessa. Il bene, anche restando come sbiadito nello sfondo, è più consistente che non appaia, più consistente del male che lo contraddice. La vita si svolge in quanto il male risulta in effetti marginale e lascia intatta la straordinaria ricchezza dei valori di accettazione, di tolleranza, di senso del dovere, di dedizione, di simpatia, di solidarietà, di consenso che reggono il mondo, bilanciando vittoriosamente le spinte distruttive di ingiuste contestazioni. E tuttavia si insinua così il dubbio che non solo il male sia presente, ma che domini il mondo. Un dubbio che infiacchisce quelle energie morali e politiche che si indirizzano fiduciosamente, pur con una difficile base di partenza, alla redenzione dell’uomo. Una più equilibrata visione della realtà, della realtà vera, è non solo e non tanto rasserenante, ma anche stimolante all’adempimento di quei doveri di rinnovamento interiore e di adeguamento sociale che costituiscono il nostro compito nel mondo”.
Il viaggio di Aldo Moro, politicamente, è lo stesso di Baudelaire in poesia, contro il veleno del potere che genera il despota. L’ignoto di Moro è una rinascita del pensiero contro gli stereotipi della tradizione italiana, per una modernità che proponga la coscienza come congiunzione degli opposti e al centro del dibattito. Serve ancora un progetto di collaborazione nazionale ed europeo. Il discorso moroteo interpretato da molti come un colpo da maestro, un modo ingegnoso di disinnescare i partiti dalle loro posizioni precostituite, finì per dare fastidio sia ai democristiani che ai comunisti. Era inevitabile. Il compromesso storico prevedeva una pace e una resa. Una pace orizzontale all’interno del Parlamento, una resa delle prerogative altezzose della dirigenza dei partiti di governo. Moro voleva ripartire da capo, da una condizione preparatoria, che attingesse addirittura ai diritti inviolabili dell’uomo. Avallava la prevenzione per estirpare il male dell’autoreferenzialità, dell’egotismo, dell’autarchia che si era impadronita degli anni di piombo. Si appellava ai principi evangelici, alla necessità di stigmatizzare i valori prima di ogni organizzazione, di ogni intesa, di ogni accordo su piccola e grande scala. Il male che domina il mondo e l’adeguamento sociale ad un compito, puntualizzati nell’articolo di giornale, appaiono più che mai proclami che spiazzano. Risultano moniti pedagogici, fuori da ogni schema e da ogni orientamento politico, fino a rappresentare un avviso e un’esortazione inaccettabili. Moro intimidisce con i suoi richiami alla coscienza, al bene, all’onestà, alla correttezza, alla rettitudine, alla solidarietà. E’ una pacificatore onnicomprensivo che rasserena gli animi, che scardina conflitti, che compone disordini. Nessun altro politico ha il suo lignaggio, la sua caratura specie morale.
Oggi non è cambiato alcunché senza l’apporto di Aldo Moro, se anche un sociologo attento come Ilvo Diamanti, parla della scomparsa del futuro, scrivendo il 19 agosto 2013 su “la Repubblica”: “In fondo, anche noi ci siamo adattati. Alla scomparsa del domani. Così invecchiamo senza rendercene conto, perché insieme al tempo, abbiamo abolito i giovani e la gioventù, dal nostro orizzonte. Stiamo diventando professionisti dell’incertezza. Navigatori dell’eterno presente. Ma proseguire in questa direzione ancora a lungo pare impossibile. Se il futuro è scomparso, restituiteci ameno il passato”.
Già, il passato e i suoi ideali. Perché il futuro non può correre solo sulla piattaforma virtuale di questo eterno presente, nell’immagine smagata, nella finzione gergale. Non siamo più corpo e voce, ma immagine e informazione. I social network appaiono alienanti, seppure transnazionali, planetari. La politica non afferra la tensione costruttiva di un progetto di lungo termine, di un divenire in forma sociologica. Non esprime la contraddizione con la parola. Resta una ferita aperta che sanguina, lo strappo in una prospettiva di affezione alle cose che appartengono alla dimensione pubblica perché di tutti. Nulla passa più attraverso l’indagine empirica della relazione sociale, come voleva Moro. La politica non si autodetermina, non è sufficiente a se stessa, perciò rimane svincolata dai bisogni e ignora ciò che dovrebbe costituire l’oggetto più intimo della sua ricerca. Il futuro umano è sempre un futuro sociale, e la dimensione umana è fondamentale per anticipare e costruire il futuro. La politica, invece, non fa previsioni. Non sa farle. Si dimentica la sfera etica della riflessione sul futuro. Se la previsione è anche produzione del cambiamento, allora includere la conoscenza e coloro che ne sono portatori, costituisce un aspetto di importanza fondamentale. La politica è bloccata nella sua ordinaria funzione, nell’amministrazione della quotidianità. Non ha uno scopo se non la sopravvivenza di corto respiro. Un atteggiamento eticamente sensibile, viceversa, è orientato al futuro nel tempo della coniugazione. Ma questo non accade mai. La politica non analizza i fatti sociali, non consiglia, non si rende scienza interdisciplinare. Quindi non si modernizza, non dà sostegno dell’azione umana.
Con ogni probabilità, nel prossimo ventennio, sarà la società del sapere a battere la corporazione politica. Sarà una comunità civile più preparata a debellare l’asfissia dei partiti. Non serve neanche l’eccessiva protesta, ma il sostegno alla conoscenza scientifica, per mettere al bando gli errori di chi ci governa, ad ogni livello. La società della conoscenza richiede di rapportarci con un sapere dalle caratteristiche dinamiche e complesse. Promuovere la formazione degli strumenti concettuali necessari per confrontarci con i nuovi saperi e con i processi di apprendimento al loro interno, darà luogo spontaneamente ad una politica programmatica fuori dalle sedi istituzionali. In questa ottica il sapere sarà guidato da una nuova ragione fondata sulla meritocrazia.
Ma non era proprio Aldo Moro a pretendere una società corretta, equa, senza pregiudizi, quindi fondata sul riconoscimento obiettivo di capacità e professionalità? Non era Aldo Moro a suggerire un’attenzione ai giovani perché potessero crescere più preparati e quindi più onesti e solidali? La responsabilità di far emergere la società della conoscenza comporta una trasformazione profonda dei sistemi educativi. Non si tratta semplicemente di un adeguamento volto a riallineare la formazione con i nuovi bisogni della società, ma di far valere l’onestà intellettuale e il buon senso, prima di tutto. La beatitudine cristiana, per Aldo Moro, sembrava essere un caposaldo per far prevalere la giustizia nel mondo, traslando i principi evangelici nella loro funzione educativa per una crescita degli individui sulla via della conoscenza. Dovremmo sentirci discepoli, prima ancora che maestri. La politica è contrapposta a questo ideale perché sa dettare solo l’agenda del giorno dopo, in cui il proprio successo è legato all’insuccesso dell’altro. Il viatico seguito dai più è la personalizzazione, l’adeguamento al mondo dello spettacolo, della fiction. Celebrità e seduzione annientano mitezza e solidarietà. La politica delle scadenze non riuscirà mai a far ricomparire il nostro futuro. La nostra democrazia e la nostra Repubblica tendono a degenerare nell’anormalità delle regole che vigono. Davvero siamo arrivati a pronunciare la parola post-umanità senza sapere bene a cosa ci riferiamo, in questa politica senza più neanche un territorio?
La politica è conflittuale per sua natura. E non dimentichiamo la stretta connessione tra potere politico e potere economico. L’agire economico è fondato sulla crescita produttiva, nonostante la recessione del modello, la crisi dell’euro e la globalizzazione che hanno favorito l’apertura dei mercati dell’est, dove la manodopera costa molto di meno. Politica e produttività si connettono ai problemi immediati mentre si assiste impotenti al tramonto del capitalismo.
Afferma il filosofo Emanuele Severino a proposito dell’ossimoro del capitalismo, in un’intervista rilasciata a Paolo Ferrario e pubblicata sul “manifesto” il 3 luglio 2011: “Quando parlo di declino del capitalismo, parlo di qualcosa che presuppone anche il declino del marxismo, dell’umanesimo marxista, dell’umanesimo di sinistra. Non è che la sinistra sia in una posizione avvantaggiata rispetto al capitalismo. Ma il discorso va completato. Sia il capitalismo, sia il marxismo e le sinistre mondiali, ma anche i totalitarismi e le teocrazie, e la democrazia, le religioni e ogni visione del mondo e ideologia, si sono illusi e si illudono tutt’ora di servirsi della tecnica. Ma che cosa vuol dire questo? Che la tecnica è il mezzo con cui tutte quelle forze intendono realizzare i propri scopi (per esempio la società giusta, senza classi, oppure l’incremento del profitto privato, oppure l’eguaglianza democratica). Anche la sinistra è cioè sullo stesso piano del capitalismo per quanto riguarda il rapporto con la forza emergente della modernità, cioè la tecno-scienza. Simon Weil diceva che il socialismo è quel reggimento politico in cui gli individui sono in grado di controllare la macchina tecnologico-statale-militare-burocratico-finanziaria: l’individuo, come il capitalista, si illude di poter controllare l’apparato tecnologico. Si tratta di capire perché è un’illusione. Invece andiamo verso un tempo in cui il mezzo tecnico, essendo diventato la condizione della sopravvivenza dell’uomo, ed essendo anche la condizione perché la terra possa essere salvata dagli effetti distruttivi della gestione economica della produzione, è destinato a diventare la dimensione che va sommamente e primariamente tutelata”.
Ma la tecnica può imporsi come scopo? Questo processo procede da sé, non c’è dubbio. Conoscenza e tecnica, nell’ambito scientifico, faranno il paio con la meritocrazia e la solidarietà sul versante sociale. Il sapere condizionerà la politica, la umanizzerà. E’ un desiderio e un pronostico. Le esperienze sono sempre transitorie, diceva Aldo Moro. Rimane l’affermazione di ogni persona, in ogni condizione sociale, dalla scuola al lavoro, in ogni luogo del nostro Paese, in ogni lontana e sconosciuta regione del mondo. È l’emergere di una legge di solidarietà che potrà salvarci. Moro rigettava il cinismo opportunistico per riaffermare una legge morale, senza compromessi, che dominasse la politica, perché non ingiusta ma intensamente umana. L’attualità del pensiero moroteo, dopo decenni, si constata in ogni occasione in cui emerge un suo discorso o un suo articolo di giornale: l’uomo come vero fulcro della rinascita che si spoglia della supponenza materiale e dell’asfissia della retorica. Moro invocava la coerente applicazione di una legge morale tale da esaltare la libertà e la dignità e da rendere possibile ed anzi inevitabile una svolta storica verso un’autentica ed universale democrazia.
Al Congresso nazionale della Democrazia Cristiana, il 29 giugno 1969, espresse queste parole: “I giovani e i lavoratori sono i primi a voler fermamente un mutamento delle strutture politiche ed un rispettoso distacco. I giovani chiedono un vero ordine nuovo, una vita sociale che non soffochi, ma offra liberi spazi, una prospettiva politica non conservatrice o meramente stabilizzatrice, la lievitazione di valori umani. Una tale società non può essere creata senza l’attiva presenza, in una posizione veramente influente, di coloro per i quali il passato è passato e che sono completamente aperti verso l’avvenire. La richiesta d’innovazione comporta naturalmente la richiesta di partecipazione. Essa è rivolta agli altri, ma anche e soprattutto a se stessi. Non è solo una rivendicazione, ma anche un dovere ed un’assunzione di responsabilità. L’immissione della linfa vitale dell’entusiasmo, dell’impegno, del rifiuto dell’esistente proprio dei giovani nella società, nei partiti, nello Stato è una necessità vitale, condizione dell’equilibrio e della pace sociale nei termini nuovi ed aperti nei quali in una fase evolutiva essi possono essere concepiti. I lavoratori, e naturalmente innanzitutto i giovani lavoratori, escono finalmente dalle zone d’ombra, dai settori marginali nei quali, senza adeguato potere, erano o si sentivano ingiustamente ricacciati. Al di là della tecnica del sistema economico adottato, essi chiedono che le scelte decisive siano fatte in sede responsabile e nell’interesse generale e che essi vi partecipino, in condizione di dignità e sicurezza, nella fabbrica, nel sindacato, nella programmazione, nei partiti e nello Stato. Non accettano di essere solo parte di un meccanismo, anello di una catena, ma vogliono erigersi a consapevoli protagonisti del processo che crea la ricchezza, la distribuisce, la finalizza verso obiettivi umani. Ed essi, pur nella loro operosità, si sentono non il mezzo, ma il fine”.
Come notato da Mino Martinazzoli sul numero di luglio di “Liberal” del 1996, “Moro ha chiaro che in una società regolata da istituzioni democratiche, la Chiesa e i cristiani non devono agire come parte in una logica di schieramento, ma presentarsi come forza di mediazione non opportunistica, di pacificazione degli spiriti, di approfondimento dei valori morali, senza tuttavia pretendere il monopolio della serietà morale. La coincidenza quasi letterale di queste parole, pronunciate nel marzo 1946, con le espressioni che il Concilio Vaticano II vent’anni più tardi avrebbe utilizzato nel descrivere il rapporto tra fede e politica, è segno dell’anticipo con cui Moro sapeva individuare i processi in atto e riusciva a prevederne gli esiti. Ma lascia intravedere, al tempo stesso, l’isolamento e l’incomprensione di cui spesso soffrì. La seconda osservazione è invece di ordine psicologico e riflette la sensazione che nella vicenda politica di Moro un ruolo non indifferente sia stato determinato da una connotazione di carattere generazionale. Si avverte nella sua presenza un’autorevolezza, riconosciutagli del resto anche con la nomina a vice presidente del gruppo democristiano nell’assemblea, che sembra non avere rapporto con l’età anagrafica e neppure, in certo senso, con la preparazione politica. A differenza di tanti maestri presenti all’assemblea costituente, Moro aveva quella qualità, rara anche nei grandi intellettuali, di intuire i processi di lungo periodo, cogliendone sotto le apparenze i segni dispersi. Il modo di agire e di pensare di Moro è già intimamente politico e ciò lo rende oggettivamente diverso dagli altri professorini che insieme a lui condividono l’avventura costituzionale: La Pira, Dossetti, Lazzati, Fanfani, e nei confronti delle cui posizioni, talvolta intransigenti, assume spesso un compito di mediazione per favorire l’intesa con le componenti politiche e ideali di segno diverso”.
Allo stesso Mino Martinazzoli non sfugge l’accesso alla direzione politica del Paese di ceti sociali prima esclusi, e quindi la libertà e il pluralismo dell’azione politica di Moro, la riduzione del distacco tra la gente e il sistema affinché si desse vita ad una democrazia compiuta, con il realizzarsi delle condizioni per un’alternativa di governo. La strada del centro-sinistra era una vera e propria scommessa che incontrava l’opposizione di molti, dentro e fuori i partiti.
Martinazzoli ricorda Moro come mediatore estenuante che intende annullare ogni discontinuità tra chi ha responsabilità di governo e chi dovrebbe invece svolgere un ruolo di opposizione: “Il disegno di condurre verso il centro tutte le forze politiche del Paese, e in particolare le grandi forze popolari, non è finalizzato a una esangue indistinzione delle responsabilità politiche e delle identità culturali. Persegue piuttosto l’obiettivo di superare le reciproche delegittimazioni e di ricomporre le fratture ideologiche, per creare le condizioni di una competizione politica regolata da un pieno accordo sui fondamenti della convivenza democratica. Questa idea di una regolamentazione concordata della contesa politica è costante lungo tutta l’azione di Moro, sia pure scandita in fasi diverse. Alla Costituente è presente come nota di fondo, non formalizzata eppure sempre richiamata nella definizione delle linee architettoniche della casa comune. Negli anni Sessanta si realizza nel centro-sinistra e nell’impostazione a livello parlamentare di un cauto rapporto di reciproco rispetto con il Partito Comunista. Negli anni Settanta prende la forma esplicita del confronto con il Partito Comunista e dell’esperienza di solidarietà nazionale. Ma l’obiettivo resta lo stesso, e cioè la progressiva corresponsabilizzazione di tutte le forze democratiche del Paese, culturali e politiche, per affrontare in termini il più possibile solidali i problemi di cambiamento e di accresciuta complessità della società italiana”.
Mino Martinazzoli parla di sfida dell’emergenza che richiede necessariamente una soluzione politica eccezionale in grado di far fronte alle spinte disgregatrici che minacciano le istituzioni democratiche. Moro ribadì la centralità del Parlamento riducendo l’autonomia dell’esecutivo. L’inserimento di soggetti nuovi e sempre più esigenti all’interno del circuito politico, necessitava di una nuova dinamica sociale, di un processo di istituzionalizzazione dell’intero sistema. La crisi puntualmente si determinò, forse prima ancora di quanto Moro immaginasse. Limiti istituzionali sommati a limiti politici avevano infatti reso sempre più incerto quell’equilibrio tra rappresentanza e decisione che Moro considerava essenziale per il corretto svolgimento del delicato processo di modernizzazione del sistema politico italiano. Una democrazia compiuta doveva riconsiderare il rapporto Stato-società nell’intervento sulle istituzioni, ma anche nella riconsiderazione della società civile. La società civile era autonoma e vitale, mentre il sistema politico appariva decisamente invecchiato.
Nota Martinazzoli: “La crisi ha affievolito i legami sociali e civili, il tramonto delle ideologie ha di fatto incupito più che rischiarato l’orizzonte culturale e politico, lasciando il campo a un diffuso scetticismo anziché a un esercizio di razionalità critica. La secolarizzazione ha ridotto, se non addirittura reciso, la possibilità di riferirsi a un comune patrimonio di valori etici e religiosi. In questo scenario, la politica è venuta rinunciando alle proprie responsabilità, rassegnandosi all’impotenza, manifesta nell’incapacità di sondare i nuovi compiti dello Stato di fronte all’esplosione di complessità della società civile. Eppure Moro non pensava che tutto fosse perduto. L’obiettivo diventa così l’accordo a livello parlamentare ed eventualmente anche governativo, che consenta di valorizzare il ruolo dell’autorità dello Stato per il rafforzamento dell’ordine pubblico e l’assestamento del sistema economico. Perciò immaginava che, dopo un periodo oscuro della nostra storia che l’esperienza della solidarietà nazionale avrebbe consentito di superare, suggellando finalmente il compimento del faticoso processo di unificazione dell’Italia moderna, si sarebbe aperta una nuova stagione, in cui la politica avrebbe potuto affrontare il vero e grave problema dei nostri anni: la stanchezza della democrazia”.
Aldo Moro profeta di una parola salvata: la pace per un patrimonio di persone, per una qualità etica. Lo statista voleva pacificare le istituzioni, le relazioni, ma prima di tutto l’uomo. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio, è riportato nel Vangelo di Matteo al quale si ispirava. Il messaggio di salvezza riguarda ancora le realtà politiche, perché si rivolgono al cuore dell’uomo e quindi alle strutture che regolano la vita pubblica. L’uomo di pace guardava alle persone, alla società, e si mobilitava per un progetto politico. Aldo Moro non si accontentava di testimoniare, ma voleva convincere per portare soluzioni migliori.
Quando ci si affronta a muso duro la cosa funziona esattamente come nel branco, in cui c’è sempre chi attira l’attenzione e guida gli altri. Il capobranco è l’animale che si guadagna il rispetto, la stima e la sottomissione degli altri dimostrando esperienza, coraggio, ma anche capacità di comunicare efficacemente e rapidamente. Aldo Moro questo lo sapeva fare come nessuno. Era l’unico che riconduceva all’ordine, alla mediazione e alla pacificazione. Voleva discutere e adottare risoluzioni su questioni di carattere generale, commissionare studi, elaborare progetti di dichiarazioni o di convenzioni, promuovere lo sviluppo del diritto internazionale dei diritti umani.
Flavio Lotti, attuale portavoce della Tavola per la Pace e direttore del coordinamento nazionale dei diritti umani, lamenta che i costruttori di pace hanno perso la capacità di mobilitare le persone. Probabilmente manca un intervento che non sia indotto, ma suscitato attraverso un’opera di convincimento. A questo compito debbono pensare i maestri di pace, che oggi non ci sono più. Il potere conduce ad una guerra psicologica per creare disinteresse verso la politica in generale e verso le questioni di guerra e di pace in particolare. La guerra psicologica serve anche per accrescere il sentimento di inutilità della lotta e ad indurre alla rassegnazione. Il movimento pacifista ha come obiettivo di contrastare il verificarsi di guerre e di ridurre, per quanto possibile, la violenza garantendo la sicurezza sanitaria, implementando diritti umani fondamentali, compreso l’accesso universale almeno a livelli minimi di sopravvivenza di aria, acqua, cibo, assistenza medica e giustizia sociale. È caratterizzato dalla convinzione che gli esseri umani non dovrebbero farsi guerra o ingaggiare violenti conflitti etnici a causa di lingua, razza, risorse, o conflitti etnici a causa di religioni o ideologie. Le missioni di pace nascono dalla solidarietà internazionale e dal dialogo fra i popoli, nell’ottica che nessuno può essere lasciato solo nella risoluzione dei propri conflitti nazionali e internazionali. Queste missioni sono volte a mantenere la pace con un’attenzione particolare nei confronti della popolazione civile che è quella più indifesa e danneggiata. Un obiettivo di più ampio respiro delle missioni di pace, è la stabilità a livello internazionale e, negli anni più recenti, la lotta contro il terrorismo.
La prima missione di pace della storia venne autorizzata nel 1948, con il nome di United Nations Truce Supervision Organization allo scopo di sorvegliare il rispetto dei trattati che vennero firmati fra Israele, Siria, Egitto e Giordania. Ebbe una durata lunghissima a causa della grande instabilità geopolitica del medio Oriente, e venne sospesa solo nel 2006. Aldo Moro aveva intuito che non bisogna rinunciare allo sviluppo della società democratica per sviluppare il processo di liberazione dell’uomo. Solo un libero dibattito porta alla pace, perché la democrazia, nel suo vero significato, è liberazione dalla necessità della violenza ed affermazione della personalità al di fuori del contrasto di potenza. Il mondo sarà pacifico se sarà democratico. La democrazia, senza eliminare di colpo le tensioni, garantisce la pace politica. Per garantire la pace bisogna tener presente le condizioni dell’equilibrio mondiale. Se non le valutassimo, potremmo mancare al nostro dovere di assicurare per noi e per le generazioni future, la libertà e l’indipendenza del Paese.
La differenza sta tra il pacifismo e la pacificazione, quindi. La parola salvata di Aldo Moro è una splendida promessa di fede, una riparazione per assicurare il bene, per innalzare l’uomo da un gradino inferiore. La persona e il pubblico sono la stessa cosa. Il singolo non è danneggiato per il suo asservimento al pubblico, poiché anche la libertà del pubblico e la libertà dell’individuo si equivalgono. Esattamente come la persona e il pubblico si suddividono fra loro il bene, così si suddividono la libertà.
*
È incredibile che il caso Moro non si pacifichi. È incredibile che la soluzione del dilemma sia ancora lontana, anche se anno dopo anno si aggiungono pezzi smontati a quei 55 giorni di prigionia, al prima e al dopo. Ma il tutto si ingarbuglia perché i rapporti internazionali dell’epoca rendono la nebulosa non attraversabile, il nodo inestricabile.
Il cimitero di notte, a Torrita Tiberina, dove per Maria Fida Moro è morta la felicità, dove il giorno della tumulazione del padre c’era una pioggia minuta, leggera, che dava altro dolore alla famiglia, mi appare in una visione fantasmagorica. Ho sempre pensato, quando i cancelli sono chiusi e le luci fioche dei lumini sembrano iridescenze provenienti da un altro mondo, che le anime dei defunti si elevino in alto e incomincino, come folletti, a ridere di noi, a spiarci. Noi domandiamo e loro rispondono senza farsi sentire, ma possiamo cogliere l’intensità dall’evocazione.
*
La storia va riscritta. L’intesa tra Moro e Berlinguer, in piena era Carter, comportava effetti destabilizzanti e alla Casa Bianca era motivo di preoccupazione. Il Partito Comunista avrebbe creato problemi di sicurezza all’interno del Nuclear Planning Group della Nato. Un documento dei servizi segreti precisava che l’intesa non trovò il consenso degli 007 della difesa, delle forze armate e della Cia, per i quali si trattava di una “formula benigna” che nascondeva i veri obiettivi della sinistra italiana. il Partito Comunista avrebbe operato al fine di ridurre l’influenza americana nella Nato ed in Europa, in particolare ridimensionando la presenza militare statunitense nel Paese. Quindi il compromesso storico era da bloccare.
Qual era il covo di Firenze, spesso citato, dove si riuniva la direzione strategica delle Brigate Rosse e dove in un primo momento fu portato il memoriale, stando alle testimonianze? Che fine hanno fatto i verbali delle riunioni dei comitati di crisi durante il sequestro? Se gli stessi brigatisti dicono che la Renault 4 fu lavata bene prima del suo uso finale, come si spiegano le tracce trovate su di essa, come bitume, sabbia tipica del litorale laziale poco a nord di Fiumicino, tracce di terreno vulcanico, residui vegetali tipici di zone vicine al mare? Come mai l’Hyperion, misteriosa scuola parigina di lingue, aveva aperto una sede a Roma poco prima del rapimento Moro per poi chiuderla poco dopo la sua conclusione? Che ruolo ha avuto la fantomatica organizzazione chiamata Anello nelle presunte trattative per liberare Moro pagando un riscatto? Chi erano i brigatisti con i quali erano in corso le trattative?
Ci sono molte carte riguardanti la vicenda Moro e le Brigate Rosse negli archivi della Stasi. A rivelarlo è la nuova edizione accresciuta del libro scritto da Antonio Selvatici dal titolo Chi spiava i terroristi edito da Pendragon. Il volume segnala che, tra i molti incartamenti, c’è una scheda intestata a Valerio Morucci in cui, sul retro, si rinvia ad un non meglio precisato “Archivio Moro”. Nonostante le ricerche accurate, gli archivisti di Berlino non hanno trovato nulla.
Scrive Antonio Selvatici sul “Giornale” il 14 agosto 2013: “Tutti allineati e coperti: la nuova Commissione sul caso Aldo Moro va fatta. I politici sembrano, sia pure con scopi, toni e finalità differenti, tutti afflitti a recitare una sorta di mea culpa con in gola quella amara sensazione che si sente quando si esprime unanime cordoglio. Ma cosa succederà quando il recitante buonismo dovrà scontrarsi con le decisioni del Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)? Quelli che hanno studiato le carte lo sanno bene: una buona partenza della Commissione d’inchiesta incomincia con lo studio delle carte segregate della Commissione Mitrokhin. Preziosi documenti da tempo inaccessibili perché subito resi indisponibili. Il volgere lo sguardo verso est potrebbe creare molti mal di pancia a chi fino ad ora ha preferito che si guardasse altrove. Mentre gli archivi dei servizi segreti degli ex paesi comunisti rilasciano una grande quantità di documenti, il nostro Copasir avrà il coraggio di desecretare e versare tutti i documenti all’archivio della nuova Commissione Moro? I deputati e i senatori dell’organismo di controllo dei servizi segreti dovranno fare i conti con quel tagliente senso di colpa su quello che lo Stato poteva o deva fare”.
Nella lettera del 30 aprile pubblicata il 1° maggio 1978, Moro scrive: “Da che cosa si può dedurre che lo Stato va in rovina se, una volta tanto, un innocente sopravvive e, a compenso, altra persona va, invece che in prigione, in esilio? Su questa posizione che condanna a morte tutti i prigionieri delle Brigate Rosse, è arroccato il governo, è arroccata caparbiamente la Democrazia Cristiana, sono arroccati in generale i partiti con qualche riserva del Partito Socialista, riserva che è augurabile sia chiarita d’urgenza e positivamente. Nessun responsabile si nasconda dietro l’adempimento di un presunto dovere. Le cose saranno chiare, saranno chiare presto”.
Torniamo alle ultime ore. Sappiamo che nelle trattativa per la liberazione sono coinvolti padre Enrico Zucca e don Antonello Mennini. Il frate sostenne di aver raccolto due milioni di dollari e si impegnò a trovarne di più. Disse anche di aver incontrato un brigatista in un confessionale di una chiesa di Milano. La trattativa sembrava andata in porto.
Nel libro di Carlo Cremona dal titolo Paolo VI (Rusconi 1991) è riportato: “Il patto era stato stabilito. Moro avrebbe dovuto vedere una persona amica, probabilmente Curioni o qualche altro, o Mennini. Attendevamo le coordinate per poter raggiungere Moro, confortarlo e portarselo via, libero. La mattina del 9 maggio fui pregato di attendere nella camera, presso l’apparecchio telefonico, lasciandolo il più possibile libero. I patti erano che qualcuno avrebbe dovuto visitare immediatamente Moro nella sua prigione e portagli il conforto del Papa da lui tanto invocato e l’assicurazione della libertà”.
Come già riferito, l’artificiere Vito Antonio Raso ha dichiarato che il 9 maggio fu chiamato in via Caetani alle 10 per un sopralluogo. Avrebbe scoperto il cadavere di Moro nella Renault 4. Il sangue fresco faceva presumere che fosse morto da poco. Sul posto sarebbe immediatamente giunto il Ministro dell’Interno Francesco Cossiga, il quale sembrava al corrente della morte di Moro, non dimostrandosi sorpreso. Vennero chiamati altri due artificieri per controllare le altre auto in zona e poi il portellone della Renault 4 venne aperto operando con una grossa tronchese attorno alla serratura. Questa versione è stata confermata dall’ex vice segretario socialista Claudio Signorile che sostiene di essere stato nell’ufficio di Cossiga quando, intorno alle 11, sarebbe giunta la telefonata che annunciava il ritrovamento del cadavere. Quindi gli orari della versione ufficiale non combaciano con quelli forniti da Raso. Le rivelazioni odierne sono molto interessanti, perché, qualora riscontate, implicherebbero non poche variazioni rispetto alla tesi ufficiale. Moro non sarebbe stato ucciso intorno alle 6 in via Montalcini e poi portato in via Caetani, come hanno sempre detto i brigatisti, ma in un orario successivo e in un luogo più vicino a via Caetani. Se il ritrovamento avvenne alle 10-11, la telefonata di Mario Moretti a Francesco Tritto, delle 12.30, avrebbe rivelato una notizia già conosciuta. Resta il mistero sul buco delle due ore precedenti al ritrovamento ufficiale.
Le dichiarazioni di Raso sono state rese solo nel 2013 perché Andreotti e Cossiga sono morti? Nessun altro avrebbe visto la presenza di Cossiga in via Caetani due ore prima? Chi ha avvertito la polizia? Chi lo stesso Cossiga? Non esiste una relazione di servizio di Raso, che sostiene di averla scritta, ma evidentemente fu stracciata. Era la prova di quell’intervento.
La Renault 4 è finita in un cortile della periferia di Roma. Era stata rubata qualche mese prima al suo proprietario, un imprenditore di origine marchigiana, Filippo Bartoli, che aveva immediatamente denunciato il furto. E a lui fu restituita, dopo che, interrogato più volte, alla fine risultò estraneo al rapimento e all’uccisione.
Il 22 settembre 2009 l’Ansa rivela che Francesco Fonti, un pentito della ‘ndrangheta, fu inviato a Roma il 20 marzo 1978. Incontrò il segretario della Democrazia Cristiana Benigno Zaccagnini e si rese conto che molti personaggi della Banda della Magliana sapevano che Aldo Moro e i suoi rapitori erano in via Gradoli. Fonti ebbe riscontri anche dai rappresentanti della ‘ndrangheta che stazionavano nella capitale. L’ultima certezza la ebbe il 4 aprile quando incontrò il direttore del Sismi Giuseppe Santovito, che gli chiese se avesse avuto notizie riguardo ad un appartamento in via Gradoli 96 e che era giunto il momento di liberare il Presidente Moro. Ma di ritorno a casa il suo capo Sebastiano Romeno lo gelò con l’avviso che a Roma i politici avevano cambiato idea. Fonti, successivamente, si trovò nel carcere Opera di Milano insieme a Mario Moretti e si accorse che il capo delle Brigate Risse riceveva ogni mese una busta con un assegno circolare.
In un intervento all’Ansa, l’8 maggio 2010, Paolo Cucchiarelli cita l’espressione americana per cui “la verità è come l’olio della corazzata Missouri”. Un modo di dire che paragona la verità alle bolle di olio che ancora affiorano ogni tanto nella baia di Pearl Harbour dall’ammiraglia Usa affondata dall’attacco aereo giapponese. Qualche frammento di verità sul caso Moro viene a galla ancora oggi.
Scrive Cucchiarelli: “Moro doveva essere rilasciato vivo il 9 maggio del 1978 e qualcosa di imprevisto, non concordato, accadde quell’ultima notte. Elemento questo confermato negli anni dall’ammiraglio Fulvio Martini, numero due del Sismi all’epoca, dal terrorista Carlos e dall’esponente dell’Olp Assam Abu Sharif: il 9 maggio, oltre al pagamento di un riscatto, a Milano era in atto una complessa azione per la liberazione di Moro grazie allo scambio tra esponenti della Raf prigionieri di Tito e detenuti brigatisti in mano all’Italia. Martini andò in Jugoslavia per prendere in carico i tre e portarli a Beirut, dove un aereo dei servizi segreti italiani aspettava in un angolo appartato dello scalo. La destinazione prevista era lo Yemen, base di Carlos. Una fazione del Sismi, ha raccontato due anni fa Carlos all’Ansa, cercò di salvarlo. Alcuni brigatisti dovevano essere prelevati dalle carceri e portati in un Paese arabo, probabilmente per scambiarli con i tre della Raf in mano a Tito. Oggi arrivano nuove conferme dopo che l’esponente dell’Olp Assam Abu Sharif ha detto che la trattativa venne improvvisamente interrotta dagli italiani, come sostiene anche Carlos”.
Franco Mazzola, all’epoca sottosegretario alla Difesa, disse che il governo non poteva trattare, ma poi trattarono tutti: la Democrazia Cristiana, il Papa, la Caritas. Nuccio Fava, direttore del Tg1, affermò che il segretario di Paolo VI, Macchi, gli disse che il Papa era molto dispiaciuto che Moro avesse scritto che lui aveva fatto pochino e aggiunse che Paolo VI era pronto ad ospitare Moro in Vaticano, mettendo in piedi una commissione indipendente, che tenesse in custodia il prigioniero e definisse una trattativa tra governo italiano e Brigate Rosse. Sereno Freato, tra i più stretti collaboratori dell’allora Presidente della Democrazia Cristiana, pensò che fosse arrivato un ordine dall’alto. Forse Moro fu liberato dalle Brigate Rosse e consegnato a X o Y, qualche settore deviato delle istituzioni o dei servizi internazionali.
Sempre dall’approfondita analisi di Paolo Cucchiarelli apprendiamo che il 9 maggio 1978 Fulvio Martini, il numero due del Sismi, doveva prelevare alcuni esponenti della Raf che erano in mano a Tito, due uomini e una donna che avevano avuto rapporti con le Brigate Rosse a Milano. Gli jugoslavi ipotizzarono di scambiarli con i tedeschi chiedendo in cambio dei terroristi ustascia che erano stati arrestati a Bonn dopo un omicidio. Alle 16 arrivò la notizia del ritrovamento del cadavere di Moro.
Nel 2008, intervistato dall’Ansa, il comandante venezuelano Carlos fornisce un ulteriore tassello che si incastra con gli altri: ci fu un ultimo, estremo tentativo di salvare Moro che ebbe come scenario la pista dell’aeroporto di Beirut dove un executive dei servizi segreti italiani attese invano, l’8 e il 9 maggio, che a Roma una certa situazione si sbloccasse. Una fazione dei servizi segreti italiani, favorevole allo scambio, avrebbe dovuto prelevare dalle prigioni alcuni brigatisti che dovevano essere portati in un paese arabo. A bordo di quel jet c’era il colonnello Stefano Giovannone, uomo del Sismi legato a Moro. Le cose però saltarono per l’intervento di qualcuno proprio quell’ultima notte.
È vero che durante il sequestro don Antonello Mennini raggiunse Moro nel covo delle Brigate Rosse? Francesco Cossiga ha ricordato la vicenda ai microfoni di Sky Tg24 domenica 24 febbraio 2008. Nel corso dello speciale dal titolo “Caso Moro, le verità nascoste”, il Presidente emerito della Repubblica ha detto: “Avevamo messo sotto controllo telefonico e sotto pedinamento tutta la famiglia e tutti i collaboratori. Ci scappò Don Mennini. Il giorno dopo della morte del Presidente della Democrazia Cristiana, la Santa Sede lo fece scomparire, lo nominò diplomatico e oggi è Nunzio apostolico a Mosca. Mai e poi mai la Chiesa lasciò che la polizia o le autorità giudiziarie lo interrogassero”.
Ci sono state delle basi fantasmi, gli ultimi giorni del sequestro, all’interno del Ghetto ebraico, precisamente in via Bresciani, in via della Reginella e in via Funari, come avrebbe ammesso più volte il brigatista Elfino Mortati?
Perché Francesco Cossiga parlando in suo libro del memoriale di Moro, dice di avergli rivelato che in alcuni villaggi irlandesi si addestravano i soldati che dovevano tenere l’ordine in Irlanda, quando in nessuna delle versioni di Moro è riportato l’episodio?
*
Chiamo Paolo Cucchiarelli, giornalista e scrittore dell’Ansa, che sta seguendo il caso da anni. Sono giorni che Maria Fida Moro mi invita a sentire la sua versione, che ritiene pertinente in ragione della serietà professionale, della passione che sta mettendo al servizio della causa.
“Dammi del tu, siamo colleghi. Sono in vacanza da due giorni, davanti ad una splendida montagna. Posso parlare in tutta tranquillità. La prigione reale di Moro è il nocciolo della questione, specie nelle ultime 48 ore. Il particolare dell’orario sposterebbe luogo, circostanze, movente, compartecipazioni dell’omicidio. Se il cadavere di Moro è congelato per quasi due ore prima di dare l’annuncio ufficiale e fare le riprese di conferma, ci sarà un perché. Claudio Signorile dice di essere andato a prendere un caffè da Cossiga, la mattina del 9 maggio. Ricorda che tra le 10 e le 11 ha sentito chiaramente la comunicazione arrivata al capo della polizia, Giuseppe Parlato, che riferiva dell’uccisione di Moro e di via Caetani. Nell’archivio della Commissione stragi è stato depositato un documento, mai reso pubblico, che dà conto di questa telefonata arrivata molto prima di quella ufficiale delle 12.13. Il problema si sposta dalle Brigate Rosse allo Stato, perché il buco di due ore apre un capitolo nuovo, sorprendente, sul quale ho lavorato per otto mesi. C’è da capire cosa successe in quelle due ore. Se si sapeva della morte di Moro tra le 10 e le 11, perché la telefonata a Tritto viene fatta alle 12.13? E perché farla, se lo Stato era a conoscenza dell’avvenuta esecuzione? Chi aveva informato la polizia e le istituzioni prima delle 12.13? Perché la telefonata a Tritto non viene fatta intorno alle 10-11?”, riflette Cucchiarelli. “Tu cosa pensi?”. Tira un sospiro e commenta laconicamente: “L’omicidio fu commesso al termine di una trattativa. Entra in campo la complessità di più fasi che tesero da un lato alla salvezza di Moro e dall’altro alla neutralizzazione di quello che aveva potuto dire. C’era in corso un Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana che doveva dare il via libera al cambiamento della strategia, rovesciando la linea della fermezza. Questa è la prima ipotesi che giustificherebbe le due ore di buco. L’incontro doveva concludersi a cavallo dell’orario giusto per la liberazione. L’altra ipotesi è che bisognava dare modo ai brigatisti di allontanarsi e di ripulire il campo dell’operazione. Ma i brigatisti e lo Stato non si fidavano affatto l’uno dell’altro. Alla fine ha prevalso un interesse convergente che legava e lega ancora i soggetti tra contesti, luoghi e situazioni accadute in quelle due ore”.
*
Ho sistemato la mia cartella giornaliera dove sono appuntate le date del caso Moro, una ad una, sottolineate con il pennarello rosso o blu secondo l’importanza. Ho scritto la lista degli articoli di giornale consultati e nel mio scaffale, in camera da letto, ho sistemato tutti i libri che ho letto e riletto. Il volto di Aldo Moro mi perseguita, come quella voce suadente che non parla più. Ma quando sono i morti che fanno parlare di sé, vuol dire che hanno ancora qualcosa da dire.
Rolando Fava, ex fotografo, ha dichiarato all’Ansa il 9 maggio 2008: “Mi ha subito colpito il silenzio irreale. Ma io non avevo alcuna idea che potesse trattarsi di Moro, quando sono entrato in Palazzo Caetani (e ho potuto farlo solo passando da una entrata secondaria che conoscevo, sul retro) e ho chiesto al portiere il favore di affacciarmi da una finestrella un metro per un metro del suo appartamento, al piano rialzato. Da lì ho scattato le immagini degli artificieri che aprivano prima il cofano anteriore, poi il portabagagli. Solo allora qualcuno ha levato la coperta e ho visto Aldo Moro in quella posizione un po’ innaturale. Credevo ancora che fosse drogato, che dormisse. Ma è stato per poco, subito la strada si è riempita del dolore di tutti”.
È come se sentissi la morte di Aldo Moro più vicina. Come se potessi fotografarla, ma non nel suo corpo disteso, rannicchiato nella Renault 4. È una morte angelica, se vogliamo: quella del Cristo che risorge, o di Lazzaro splendente di luce. La morte, in fondo, rappresenta il massimo grado dell’indicibile. La parola non la coglie e non la spiega. La fine di Aldo Moro non è stata riscattata, per questo brucia. Non fa male perché è avvenuta, ma per come è stata impartita, cioè innaturalmente, violentemente. E per come è stata taciuta l’esecuzione. L’azione, in questo caso, ha avuto più valenza del fine. Ma l’azione rimane occulta, come la ragione dell’uccisione. Ogni assassinio è illogico e maledetto. Ecco perché dovremmo preferire Moro vivo prima degli stessi 55 giorni di prigionia, ed ecco perché non dovremmo rassegnarci al gesto inaccettabile di chi gli ha sparato. La morte dello statista è stata una grande sconfitta dell’Italia repubblicana, uno spettro ignobile nascosto in un angolo della mente oltre che nei segreti di Stato e nelle carte del memoriale. Ma Aldo Moro irrompe durante il giorno, e non lo si può ignorare. Insegna anche da morto, parla nel silenzio abissale. E’ un assente che presenzia, è un vivo tra i vivi. E’ un esempio di martirio che ci permette di conoscere meglio l’uomo, il marito, il padre, il nonno, il politico. Non potranno nascondere mai la sua parola. E’ come dire che ci incoraggia a vivere, 35 anni dopo.
*
Marina, la mia compagna, ha letto il dattiloscritto. Seduta sul divano beve il suo thè. “Ma tu come la pensi?”. “Ci sono, ormai. Compartecipazione, si dice, ma sarebbe semplicistico ridurre la vicenda ad un generico aggettivo”. “Spiegati meglio”. “Il caso Moro ha più piani di sequenza, più sviluppi sia nella preparazione, che nell’esecuzione, che nel nascondimento della verità, opportunamente taciuta per un patto tra i brigatisti e lo Stato successivo alla morte di Moro e che dura ancora oggi, nonostante siano deceduti i maggiori complottisti. Ognuno teneva un testimonio in mano, all’epoca. Quando lo passava non sapeva e non poteva sapere cosa avrebbe fatto l’altro. Ogni lascito era definitivo e interrompeva bruscamente un ruolo deciso a tavolino nei 55 giorni del sequestro”. “Perché?”. “Perché erano impegnati Stato, servizi segreti, italiani e stranieri, e brigatisti. Una vicenda con molti attori, alcuni non protagonisti, malfidati l’uno dell’altro. Il compromesso storico non poteva essere realizzato, perché gli Stati Uniti tutelavano i segreti militari, il patto Atlantico e le postazioni strategiche della Nato. Anche l’Unione Sovietica guardava con sospetto il segretario del Partito Comunista Berlinguer, che si muoveva autonomamente in piena Guerra Fredda nel paese occidentale dove il comunismo aveva il più largo consenso. Nessuno, però, poteva prevedere la comparsa del memoriale. Quando Moro ha parlato e soprattutto ha scritto, gli ostaggi sono diventati due. L’uomo e il suo memoriale. Moro aveva rivelato segreti di Stato, non poteva essere salvato se non con la restituzione del memoriale, che interessava più della sua vita. Lo Stato pretendeva assolutamente la consegna degli scritti, dei verbali dell’interrogatorio e delle bobine nelle quali era stato registrato l’interrogatorio dalla prigione del popolo. E a quel punto, una volta liberato, Moro si sarebbe ritirato dalla politica”. “Perché la trattativa è fallita?”. “Trattava lo Stato, Fanfani in testa, e trattava anche il Vaticano per espresso volere di Paolo VI. Per la restituzione del memoriale e dell’altro materiale i brigatisti chiedevano quaranta miliardi. Avevano un asso in mano”. “Troppo?”. “Forse no, ma qualcosa si è inceppato”. “Chi ha sparato?”. “Forse Mario Moretti, ma non in via Montalcini”. “Dove?”. “Nel luogo dove doveva concludersi positivamente la trattativa e dove Moro era stato condotto, quella mattina. Un luogo molto più vicino a via Caetani”. “Era convinto che lo avrebbero liberato?”. “Sì. Quando i brigatisti uscirono con la Renault 4 era per liberare Moro”. “Quante furono le prigioni in quei 55 giorni?”. “Più di una, sicuramente, forse anche in via Gradoli”. “E nel litorale laziale?”. “Probabile. Si sono spostati più volte. I segreti di Stato restano alla base della morte. L’hanno ammazzato perché aveva parlato”. “Resta il fatto che i brigatisti non hanno fatto trapelare nulla di ciò che Moro ha detto e ha scritto, neanche dopo trent’anni. Nessuna divulgazione, come invece era stato promesso, utilizzando la stampa alternativa. Il memoriale resta un documento scottante, censurato più volte, che ricostruisce la crisi italiana e specialmente le vergogne della Repubblica. Scritto a mano, fotocopiato e battuto a macchina dai brigatisti, è stato al centro di una rete di ricatti e forse di delitti. Ne sono stati coinvolti Dalla Chiesa e Andreotti, Gladio e la P2. La trattativa tra lo Stato e i brigatisti è proseguita anche per evitare che fosse reso pubblico ciò che Moro ammise sui rapporti tra Michele Sindona e Giulio Andreotti. Andreotti è definito un regista freddo, imperscrutabile, senza dubbi, senza palpiti, senza mai un momento di pietà umana. Tutti gli altri erano obbedienti esecutori di ordini”. “Moro era diventato scomodo”. “Oggi sappiamo che descrisse Gladio, un esercito occulto, stay-behind, presente in molti paesi europei e finanziato dalla Cia con il compito di resistere in caso di invasione comunista, la cui esistenza è stata resa pubblica poche settimane dopo il ritrovamento del memoriale. Miguel Gotor ha ricostruito minuziosamente, dal memoriale, le responsabilità del golpe Borghese e della strategia della tensione, le clausole del cosiddetto lodo Moro sul conflitto israelo-palestinese in Italia, le attività della Nato e della Cia, i destinatari delle tangenti Italcasse e Lockheed. Inoltre la vicenda che riguardava il principale protagonista dell’eccidio alle Fosse Ardeatine, l’ex ufficiale delle SS Herbert Kappler. Fu fatto fuggire con una finta evasione dall’ospedale in base a un accordo con la Germania, che soltanto su quello scambio avrebbe approvato la richiesta italiana di un prestito economico”. “I brigatisti sono stati solo un mezzo?”. “Ognuno ha giocato la sua partita e qualcuno ha alzato troppo la posta in palio, come scrisse il ben informato Pecorelli”. “E il ritrovamento del memoriale in via Monte Nevoso?”. “Ha un’importanza relativa, perché quello che non doveva essere reso pubblico fu opportunamente sottratto. I documenti originali, i nastri magnetici e i documenti scritti vennero ritenuti distrutti, ma è probabile che siano stati consegnati allo Stato”. “Chi sa tutto, dall’inizio alla fine?”. “Mario Moretti, è lui la chiave per aprire la porta, l’ultima porta. Ma non parla”.
Sul sito www.archivioguerrapolitica.org, il 16 marzo 2013 Vincenzo Vinciguerra ha scritto: “Questo del trattamento riservato a Mario Moretti ed ai suoi compagni è un capitolo che si cerca di tenere segreto per evitare che gli italiani si facciano delle domande e cerchino delle risposte. Mario Moretti all’interno del carcere di Opera è stato trattato come un collega dai secondini per i quali era un intoccabile, da favorire in ogni modo. Inserito fra i dirigenti della Lombardia informatica, Mario Moretti da 23 anni riceve un lauto stipendio sfruttando il lavoro a cottimo degli altri detenuti. Nel 1993, a soli 12 anni dall’arresto, è andato in permesso premio; due anni dopo era al lavoro esterno; altri due anni, nel 1997, e gli veniva concessa la semi-libertà perché aveva riconosciuto, bontà sua, il fallimento della lotta armata. Non gli hanno ancora concesso la condizionale proprio per evitare che divenga di pubblico dominio il trattamento privilegiato di cui è oggetto. La semi-libertà, per coloro che non lo sanno, consente a Mario Moretti di stare fuori dal carcere 15 ore al giorno, festivi compresi, obbligandolo a dormire in cella la notte. È una detenzione virtuale. Sono passati 35 anni dall’agguato di via Fani, dal sequestro e dall’omicidio di Aldo Moro ma nessuno dei misteri che avvolgono quell’operazione è stato mai chiarito. Mario Moretti ed i suoi compagni hanno barattato il silenzio con i benefici di legge ed il ritorno in libertà, guadagnandosi l’appoggio di Francesco Cossiga, che sulla morte di Aldo Moro ha costruito la sua fortuna politica, della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista. Come un pappagallo ammaestrato, il direttore onorario del mandamento penale di Opera, Mario Moretti, ripete ad ogni occasione che dietro alle Brigate Rosse c’erano le Brigate Rosse, ma non ci crede più nessuno. Per un individuo come Mario Moretti la credibilità conta poco, anzi niente rispetto al conto in banca per garantirsi una serena vecchiaia, la libertà ed i privilegi di cui gode. La libertà non interessa ai brigatisti rossi che, partiti per fare la rivoluzione, si sono fermati nelle stazioni del Sismi, della Cia e del Mossad. Non è da loro che il Paese possa attendersi la verità su quanto è accaduto sul versante della lotta armata condotta dalla sinistra in Italia. Moretti ed i suoi compagni sfruttano i segreti accumulati nel corso di una rivoluzione fallita, confermando la scelta, comune ai più in questo Paese, che è più conveniente essere un cane vivo piuttosto che un leone morto. E di cani ha bisogno questo regime, che stiano silenziosi e a cuccia in attesa della scodella e dell’osso da rosicchiare. I brigatisti rossi che hanno partecipato all’agguato di via Fani e all’omicidio di Aldo Moro fingono ormai di essere tornati in libertà perché s’illudono che nessuno riesca a vedere il guinzaglio che il padrone tiene saldamente nelle sue mani. Sbagliano, sia loro che il padrone. Il giorno in cui i loro segreti ignobili non potranno più essere custoditi, perché anche i cani ed i padroni muoiono, la verità sull’affare di famiglia rappresentata dall’eccidio di via Fani e dall’omicidio di Aldo Moro emergerà in tutta la sua verità. Basta attendere”.
*
Il reportage implica sempre una grande responsabilità per i fatti che si raccontano e specie per le persone che sono coinvolte. Il caso Moro è un caso del tutto straordinario, delicatissimo, nella storia repubblicana dell’Italia.
Ha scritto Maria Fida Moro nel libro La nebulosa (Selene 2004): “La cosa più grave è la quasi assoluta mancanza di rispetto nei confronti di tutta quella sofferenza che era in ogni caso privata, intima, ed è diventata argomento di conversazione in salotti televisivi, di libri molto spesso indegni e indecorosi. Non intendo affermare che non fosse lecito parlare di un caso così clamoroso, ma avrei voluto che l’approccio fosse diverso, più umano, meno violento. E’ davvero singolare per non dire ignobile che quello stesso mancato riconoscimento politico alle Brigate Rosse che, dicono, sia costato la vita a mio padre, venga oggi dispensato, a piene mani, dai pulpiti televisivi con frivola leggerezza e sorrisetti compiaciuti. E beninteso, nei salotti mediatici i Moro, amanti della verità, non sono ammessi! Che il nostro fosse il paese di Pulcinella era già noto, ma adesso sappiamo anche che è la patria dei senza vergogna. Forse chissà, un maremoto delle coscienza potrebbe ripristinare la prioritaria legge dell’amore”.
Nello stesso libro echeggiano le parole di Francesco Tritto, il docente allievo di Moro: “Moro era un unicum assoluto. Non è possibile, pertanto, illuminarne pienamente la figura e l’opera se si tralascia quest’aspetto o si trascurano i tratti salienti della sua umanità. E il suo essere educatore, proprio di quell’umanità, rappresenta un momento caratterizzante, essenziale e costante. E pertanto, chiunque voglia cimentarsi nel fare opera di scienza e di storia nei confronti di Aldo Moro, deve avere ben chiaro un concetto: la sua figura non è scomponibile, la sua umanità costituisce presupposto per illuminare tutti gli altri momenti che hanno contrassegnato la sua esistenza terrena. Non v’è dubbio che Aldo Moro sia riuscito a far sì che rimanesse una traccia indelebile della sua umanità, di quel suo capire le cose del mondo, di quel suo cogliere in un baleno uno stato d’animo individuando, al contempo, i limiti e le possibilità espansive della persona umana, anche nei cuori impietriti di coloro che lo hanno tenuto prigioniero in quei 55 giorni”.
*
Non ho voluto costruire una narrazione fiction, perché la vicenda è realmente accaduta e la riproduco fedelmente, fatalmente, senza alterazioni o suggestioni, ma non nascondendo l’altra verità, che è come ammettere che esiste un secondo Stato. Non credo di aver adottato una forma narrativa eccessivamente esposta al dolore, né tanto meno esibita. Non c’è pudore verso la reazione al dolore, più che verso il fatto che provoca un qualunque dolore. Perché la vicenda autobiografica pone di fronte a tematiche assolute. Il confine della realtà non è mai qualcosa di dismesso, ma un’odissea.
Proprio qualche giorno fa Maria Fida Moro mi ha detto che nel suo testamento scritto dal carcere del popolo, il padre ha sbagliato la data di nascita di Luca, pur avendo una memoria inossidabile e pur ricordando ogni particolare della nascita di Luca. Se ha scritto 1976 invece di 1975 ci deve essere un motivo. Maria Fida non è riuscita a darsi una risposta, ma siamo ancora di fronte ad un episodio che dimostra la volontà di comunicare in modo cifrato, in un doppio senso di lettura. Lo stesso “dominio pieno e incontrollato” citato in una lettera, poteva essere inteso come un condominio pieno e incontrollato, senza portiere, abitato da varie persone negli appartamenti di via Montalcini dove era recluso. Il lascito più commovente di Aldo Moro è la sensazione, più volte manifestatami da Maria Fida, che quella morte sia stata vissuta come un lutto familiare da molti italiani, come se a morire fosse stato uno di casa, come se tanta gente si fosse sentita in colpa per non aver costruito una muraglia cinese a difesa di una vittima mite e innocente.
Aldo Moro deve essere ancora difeso da tutto ciò che è ipervisibilità e che prevale nettamente sulla riflessione, su ogni forma d’espressione che abbia come mezzo la parola e come risultato il componimento verbale, una proiezione dell’intelletto umano e della sua capacità di concepire ed intendere. La crisi delle humanae litterae e di ogni fattore educativo rivela il lento spegnersi di un luminoso faro, che va progressivamente perdendo la sua capacità di illuminare all’interno di una società in cui ogni generazione sperimenta un mutamento sempre più veloce e impoverito. Moro non avrebbe amato il tempo reale e il bello della diretta. Avrebbe preteso il confronto e il riconoscimento dell’uomo. Oggi si tende sempre di più ad identificare la realtà con il divismo, il sapere con il dire. La monocultura si è fatta consumo, proprio ciò che Moro avrebbe rifiutato. Nel terzo millennio non avrebbe tralasciato ogni cristallina purezza, ogni sentimento d’affetto e di amicizia. Moro era capace di dire ai suoi studenti che sentiva i loro cuori palpitare. Si donava. Il silenzio sulla sua morte deve infrangersi, perché non ci lasci ancora senza fiato, perché ci riconduca alla fiducia nella verità e non ad un assillante mormorio, ad un coacervo di opinioni e supposizioni che emergono da un abisso oscuro. La verità è evangelica, per cui l’accoglienza di un uomo risiede nel cuore della sua identità. E’ questo l’ultimo messaggio di speranza per Aldo Moro, uomo di Stato e uomo di pace. Come un Cristo pasquale non può essere considerato solo un caso da indagare. Egli va cercato come uomo, perché si possa dire che è risorto ed è vivo in mezzo a noi. Una resurrezione che tagli la nebulosa. E’ questo il principio del nuovo umanesimo cristiano: il testamento mai scritto di Aldo Moro, l’unico grande disegno originale che infrange il puzzle del sequestro e della morte. L’ultimo appello allo Stato.
*
Detto a Marina la mia stringata conclusione. È un’ipotesi, una tra le altre, ma parte da dati difficilmente confutabili e da deduzioni probabili. Una teoria, ma non un’illazione, non un castello di supposizioni nei diversi vuoti di conoscenza. Niente è completamente dimostrabile. La stessa Commissione d’inchiesta della XII Legislatura adombrò che inizialmente la criminalità organizzata si fosse attivata dall’esterno per favorire la liberazione di Moro. Tale attivazione si arrestò per valutazioni interne alla criminalità e per input esterni probabilmente coincidenti. Impressionante è la convergenza di indicazioni verso un intreccio fitto di ambigui rapporti che legarono in ambito romano uomini di vertice al mondo di un oscuro affarismo, ad esponenti politici, ad appartenenti alla Loggia P2, a settori istituzionali, in particolare dei servizi segreti.
In Italia stava prevalendo nettamente l’assoggettamento della classe politica ed economica agli Stati Uniti. Il caso Mattei, Ustica e il Cermis hanno strette connessioni con il governo americano, così come la vicenda Moro, dall’inizio alla fine. I rapporti tra Moro e Kissinger si erano fatti tesi specie dopo il viaggio dello statista italiano a Washington nel 1974. Si voleva fermare il disegno politico di Moro, ma ciò che interessava di più agli americani era lo scopo militare della Nato, soprattutto in ragione della richiesta di utilizzare le basi aeree italiane per i rifornimenti concessi da Washington al suo alleato principale in Oriente, cioè Israele. I comunisti avrebbero certamente ostacolato e impedito l’assolvimento di tale richiesta.
La trattativa segreta per la liberazione ci fu, a patto che Moro uscisse definitivamente dalla politica. Venne coordinata da uomini dello Stato, dei servizi segreti e del Vaticano, concordemente, così da maggiorare l’entità del riscatto e per utilizzare più persone di diversa provenienza nella dinamica della rischiosa trattativa che avrebbe dovuto portare alla liberazione la mattina del 9 maggio. Lo Stato non avrebbe agito all’insaputa del Papa, molto coinvolto emotivamente, e viceversa. La Santa Sede aveva raccolto quasi 25 miliardi di vecchie lire. È stato anche detto che un velo nero copriva la mazzetta che lo stesso Paolo VI vide di persona.
La Democrazia Cristiana, proprio la mattina del 9 maggio, stava per esprimersi a favore di una trattativa umanitaria accogliendo finalmente la proposta del Partito Socialista. Il Presidente della Repubblica Giovanni Leone avrebbe firmato un atto di clemenza nei confronti di un terrorista in carcere (Paola Besuschio o Alberto Buonoconto) ed era già con la penna in mano, come ammise. Ci sarebbe stato il riconoscimento delle Brigate Rosse come soggetto politico da parte di un governo estero di matrice comunista, probabilmente la Jugoslavia di Tito. Ma successe che Mario Moretti venne informato della scoperta del covo di via Montalcini da parte di infiltrati che conoscevano le mosse dei brigatisti, che pedinavano costantemente, o da persone amiche legate alle istituzioni. L’intenzione, in un primo momento, era quella di ricattare i sequestratori minacciando l’irruzione nel covo di via Montalcini e l’arresto immediato degli occupanti l’appartamento, ma c’era il rischio che Moro potesse essere ucciso durante una sparatoria. Fu proprio a quel punto che si aprì la trattativa, segretamente, ma che non aveva più ad oggetto lo scambio con i prigionieri, bensì il pagamento di un ingente riscatto. I servizi segreti avevano infatti constatato che dal carcere del popolo Moro era stato più volte interrogato, quindi lo Stato pretendeva non solo il rilascio di Moro, ma anche la consegna delle lettere non pubblicate, del memoriale, dei verbali dell’interrogatorio, nonché delle registrazioni dell’interrogatorio contenute nelle bobine. La pretesa era anche che fossero distrutte eventuali fotocopie affinché non rimanesse traccia alcuna delle parole di Moro, verbalmente e per iscritto.
Come ci informa il giudice Ferdinando Imposimato nel suo libro, i servizi segreti, posizionati al piano di sopra di via Montalcini, attraverso i loro potenti ricetrasmettitori, captarono che lo statista aveva confidato segreti di Stato sufficienti a compromettere le carriere di alcuni dirigenti democristiani, primo tra tutti Giulio Andreotti. Una volta comunicata la scoperta del covo non aveva più senso la pretesa iniziale dei brigatisti, cioè il riconoscimento politico di forza armata, né il rilascio dei tredici detenuti indicati. Non restava che pattuire un prezzo.
La mattina del 9 maggio Moro non fu ucciso alle 6-6.30 del mattino nel garage di via Montalcini, ma trasportato in un luogo, presumibilmente vicino via Caetani, dove sarebbe stata chiusa la trattativa, secondo quanto concordato in linea di massima la sera prima.
I racconti di Maccari sono pieni di buchi e di incongruenze. Non è certo chi sparò e se lo fece a viso scoperto, chi tamponò le ferite con dei fazzoletti e se effettivamente un’inquilina del piano di sopra scese in garage prima dell’uccisione, come riferito da Laura Braghetti. La posta in palio era alta, come scrisse Mino Pecorelli, e qualcuno giocò al rialzo. Può darsi che i brigatisti non volessero consegnare gli originali della documentazione o le bobine delle registrazioni, o che per farlo avessero chiesto molto di più dei presunti 40 miliardi pattuiti. È ovvio che Stato non si fidasse di loro e che loro non si fidassero dello Stato. Una volta che la trattativa saltò, Moro fu ucciso. Ecco perché l’autopsia parlò di un orario compreso tra le 10 e le 10.30.
La trattativa si svolse, stando a più di una ricostruzione, in un luogo del Ghetto ebraico, alla presenza di esponenti dei servizi segreti e delle Brigate Rosse, dove è possibile immettere un’autovettura, forse in un cortile con un passo carraio. Sergio Flamigni parla di un covo di fiancheggiatore dei brigatisti in via Sant’Elena 8 abitato da militanti della sinistra extraparlamentare. La scoperta avvenne nel giugno 1978, ed è certo che in quel covo si tennero riunioni per progettare azioni armate. ll tragitto da via Montalcini a via Caetani era troppo lungo e l’area sorvegliata da decine di poliziotti e carabinieri. Serviva un posto più sicuro, dove trattare, rilasciare Moro o eventualmente ucciderlo.
Nel covo di via Gradoli scoperto il 18 aprile 1978, gli inquirenti trovarono, insieme ad armi e documenti, un foglio scritto da Moretti con l’indicazione dell’Immobiliare Savellia. La Savellia, una società che aveva sede in via Monte Savello, nel Ghetto ebraico a poca distanza da via Caetani, era amministrata dal Presidente del collegio sindacale Giovanni Colmo, un fiduciario del Sisde. Già poco dopo il 9 maggio 1978 il giornalista Carmine Pecorelli fece più volte riferimento ad un passo carraio nel centro di Roma e disse che la prigione brigatista era situata in prossimità di via Caetani dove, di lì a poco, vennero effettuati degli scavi archeologici. A quella stessa zona di Roma fece riferimento anche il brigatista Elfino Mortati, il quale dichiarò ai magistrati di essere stato ospitato, da latitante, in un appartamento-covo situato nel Ghetto ebraico di Roma. Fu studiata l’angolatura delle ruote della Renault 4 e i risultati fecero intendere che l’auto non era stata parcheggiata provenendo dall’imbocco della strada, ma uscendo direttamente da un palazzo di fronte. La verità fornita nei processi è ancora parziale.
Gli indizi raccolti dalle commissioni fanno ormai pensare che i brigatisti avessero organizzato il rapimento come un loro progetto politico, ma che in corso d’opera abbiano avuto contatti con i servizi segreti modificando il piano. Fatto sta la trattativa fallì e Moro fu assassinato. Si doveva quindi procedere alla restituzione del corpo alla famiglia, cosa che fu fatta consentendo di sgomberare il campo dall’area di Palazzo Caetani, che peraltro, particolare non trascurabile, ospitava alcune sedi diplomatiche e confinava con Palazzo Mattei dove figurava una sede del Sisde. Entrambi i palazzi erano provvisti di sotterranei. Ci si aspettava la liberazione di Moro, invece venne rinvenuto il cadavere. Cossiga fu immediatamente avvertito che la trattativa era fallita e dove il cadavere di Moro era stato condotto a bordo della Renault 4. Questo spiega perché era presente sul luogo del ritrovamento due ore prima della telefonata a Tritto. C’era ancora da far convergere gli interessi di entrambe le parti, nonostante l’uccisione del sequestrato. Il complotto doveva arrivare ad un punto di svolta. Non è affatto escluso che sia stato pagato un riscatto per assicurarsi il silenzio dei brigatisti sulle rivelazioni di Moro, che infatti non vennero divulgate pubblicamente come invece era stato promesso. Oppure la trattativa proseguì dopo l’uccisione di Moro, con il pagamento di una somma di denaro, finché una parte del memoriale non venne scoperto in via Monte Nevoso nelle due distinte occasioni. Questo dimostrerebbe perché i manoscritti originali e le registrazioni degli interrogatori non sono mai stati trovati. Vennero distrutti o ceduti allo Stato italiano o ad uno Stato straniero perché li occultasse definitivamente. Sappiamo che durante i due ritrovamenti del memoriale, alcuni fogli furono sottratti. Si trattava di fotocopie che i brigatisti non avevano distrutto e che stavano ordinando cronologicamente. Via Monte Nevoso era il luogo temporaneo dell’archivio del memoriale. L’improvvisa scoperta del covo e il blitz delle forze dell’ordine non consentì loro di custodirlo in un posto più sicuro.
*
Marina si alza in piedi e chiude la finestra. Ripone accuratamente il dattiloscritto sul tavolo. Lo ha fatto rilegare in una cartolibreria. Ha scritto in un post it: “lavoro ultimato”. Allinea le penne e chiude le cartelline con i ritagli di giornale e le fotocopie, prima di sistemarle negli scaffali della libreria di casa. Guardiamo il plico mentre usciamo dalla stanza quasi intristiti. La voce che mi parla da non so dove si è quietata. Sarà per sempre.
Alessandro Moscè